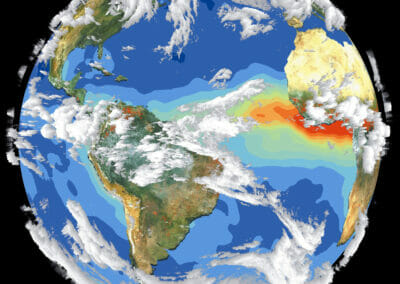Ognuno di noi, abitante del pianeta Terra, la mattina si sveglia e sa… che dovrà vestirsi. Apre il suo armadio – o guarda una sedia, o raccoglie da terra i propri vestiti – e li indossa. Un gesto banale e scontato: mettiamo il nostro corpo all’interno di spazi vuoti. Infiliamo le gambe in cilidri di canvas, allarghiamo le braccia in tubi di lino e cotone. Calchiamo la testa in scodelle di lana o paglia. Con diverse gradazioni di fortuna e benessere economico, scegliamo degli abiti, a seconda del nostro stato d’animo, del retaggio culturale – sia un gonnellino di paglia hawaiano, un kaftan africano, un kimono orientale – della moda del momento, e abitiamo uno spazio.
Lo stesso gesto si ripercuote nei luoghi in cui viviamo. Abitiamo case, posti di lavoro, strade e quartieri, comunità e città; alcuni di questi li abitiamo simultaneamente e senza pensare, spesso, a quale sia il nostro impatto – il nostro abito fisico – nell’ambiente in cui siamo calati, volenti o inconsapevoli. Abitiamo, governati da forze ben più ampie e complesse, tra politica e società, scambi commerciali e culturali, indossando edifici che non abbiamo scelto e mezzi pubblici spesso stretti e scomodi, lungo strade claudicanti, in città che stringono e affannano al collo.
Si tratta, in sostanza, di ripensare allo spazio abitato: “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”, così come recita il goal n.° 11 dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile. Includere, assicurare e durare: tre pratiche sociali che hanno sempre contraddistinto la creazione di una comunità e, nelle sue concentrazioni, le città. Perché dunque ridefinire qualcosa di già assodato? Cos’è questa “moda culturale in cambiamento”? Vi sono delle differenze rispetto ai concetti già conosciuti di inclusione, sicurezza e durata?
Per quanto riguarda l’inclusione, possiamo storicamente affermare che gli esseri umani si sono aggregati, e hanno quindi incluso più facilmente, persone con gli stessi interessi, le usanze simili, obiettivi in comune. Spesso queste caratteristiche erano conformate dalla geografia dei luoghi abitati, dagli spazi più grandi di quanto uomini o donne potessero coprire a piedi o a cavallo; in sostanza, dalle aggregazioni naturali, esterne o interne all’essere umano. Il paradigma è cambiato, nel momento in cui l’artificio, la produzione dell’umanità stessa – la tecnica – ha creato un ambiente diverso, con una propria potenza e una propria legge, sulla quale l’essere umano si illude di poter comandare a piacimento.
L’esistenza dell’inclusione presuppone in sé l’esistenza anche di una esclusione, di qualcuno da lasciar fuori. Da qui l’idea di sicurezza: il senso di protezione per la propria comunità tanto dagli eventi atmosferici quanto da altre comunità, più o meno diverse, più o meno “esclusive”. La prevenzione, la diffidenza, l’ignoranza e l’ostilità hanno fatto sì che il conflitto divenisse, nel corso della storia, una sorta di “male necessario” per il progresso – tecnologico – di una parte del mondo. Si vis pacem, para bellum, su di un crinale scosceso e pericoloso, dove spesso siamo inciampati e caduti nella tragedia della sofferenza.
Assicurare sicurezza, dunque, per durare nel tempo e perpetrare la propria comunità, le proprie città, anche a discapito dell’altro, dell’escluso e dell’incompreso. Una peculiarità propria del mondo occidentale che difficilmente ha pensato, nelle proprie culture, al “tramonto” di una civiltà, ma piuttosto al suo “accanimento terapeutico-culturale”. Restio all’accettazione del cambiamento e del mutare, e incline alla modifica e alla forzatura delle proprie ragioni e della propria potenza, intellettuale ed economica, l’Occidente ha agito per segnare nei libri di storia il proprio passaggio nel mondo, dimentico del fatto che, perché presente in un libro di storia, per definizione è “già passato”.
Manca però un aggettivo, rispetto alla declinazione dell’undicesimo goal dell’agenda 2030: quel “sostenibile” che impone una nuova discussione e una ridefinizione di inclusione, sicurezza e durabilità. La sostenibilità che si vorrebbe professare e attuare a livello globale impone un dialogo inclusivo tra diverse culture: la potenza occidentale, lo sviluppo orientale, la povertà australe, l’ecosistema del pianeta nella sua globalità. È tutta qui la differenza tra passato e futuro: non è più possibile escludere le ragioni di una comunità o dell’altra, nonché di quelle naturali; si tratta di “includere le esclusioni”, o le diversità. Preservare le diversità identità culturali significa darsi la possibilità di affrontare un problema attraverso i diversi punti di vista, per attuare la risoluzione migliore.
“Includere le esclusioni” implica una resa della sicurezza emergenziale, fatta di mera difesa contro l’estraneo; assicurare la sopravvivenza di una comunità sostenibile si traduce nella difesa dall’erosione di spazi e risorse, nel discernimento di ciò che è realmente utile, e non succedaneo, alla vita quotidiana, rispetto a ciò che invece può essere lasciato al prossimo, non solo a livello spaziale ma soprattutto a livello temporale, ovvero ai posteri. E ciò implica, giocoforza, un durare nel tempo, non come egemoni della propria era ma come co-esistenti dello stesso pianeta, dello stesso modo di abitare la Terra.
È veramente un modo – o una moda – che cambia, resa necessaria dal cambiamento degli spazi attorno a noi. L’ambiente non è, e non sarà più, quel che già abbiamo conosciuto. Non è più l’essere umano a modificare lo spazio attorno a sé, ma viceversa: lo spazio torna a ridefinire, dopo secoli di sfruttamento, l’ambiente umano. E sia esso naturale o artificiale, è comunque doveroso aprire l’armadio delle nostre pratiche abitative e ripensare a cosa dovremo indossare nel prossimo futuro, tra edifici riciclabili, trasporto leggero, ambienti condivisi. Nell’aria di primavera, un nuovo modo di spazio abitato.