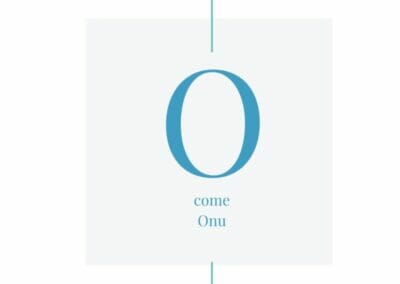“Keep calm and che mondo sarebbe senza megl’ che uan?”
Si ammetta il virtuosismo pubblicitario, questa crasi dello slogan: un grido di guerra che urla negli occhi e nelle orecchie di noi consumatori tra giornali, televisioni e schermi intelligenti. Un invito piacente al comprare e usare – e spesso abusare – del mondo materiale che ci sta attorno. È il capitalismo (baby), il movimento economico che ha comportato, poi, quello sociale del consumismo: creare bisogni succedanei, per aumentare il profitto, senza misura di confine e soddisfazione. È la linea retta, apparentemente infinita, di produzione e consumo: generare per consumare, lasciando nel mondo ciò che rimane.
A pochi giorni dal Country Overshoot Day italiano – quest’anno il 19 maggio, nella media degli ultimi lustri – c’è da chiedersi concretamente cosa voglia dire produrre e cosa voglia dire consumare: quale sia la loro definizione, cosa implichi, che tipo di ripercussioni abbiano queste azioni nelle comunità e sul pianeta Terra. La pregnanza scientifica della nostra cultura digitale ci permette di parametrare e calibrare il nostro impatto, e le conseguenti contromisure ambientali che adotta la Natura per bilanciare il rapporto con l’essere umano. In altre parole: cambiamento climatico.
Tra definizione e fascinazione etimologica, “produrre” – dall’antico “producere” – significa “generare” e/o “condurre fuori”; il suo sostantivo, “produzione”, suggerisce un “allungare, prolungamento”. L’idea è che produrre possa voler dire da un lato “generare”, da un lato “aumentare” in qualche modo la vita dell’oggetto. È realmente così? Il signor Antoine-Laurent de Lavoisier potrebbe dissentire: la massa si trasforma, dai reagenti al prodotto. Non si crea e non si distrugge. La legna che arde diventa fumo, cenere, carbone e energia dispersa. Una falsa generazione su larga scala, dove in realtà la produzione – di mercato – non implica altro che un’immensa catena di trasformazione, a uso e consumo dell’uomo e per la sua sopravvivenza. E qualcosa più in là.
Se fino alla rivoluzione industriale, infatti, ciò che veniva prodotto, in larga scala, era lo stretto necessario per la stragrande maggioranza della popolazione – e con un ingiusto vantaggio spropositato per nobili e potenti, che potevano ostentare ricchezze e opulenza – con l’avvento della meccanizzazione il mercato si è democratizzato (almeno apparentemente). Larghe fasce di popolazione, occidentale o in via di sviluppo, può usufruire di bene necessari e non-necessari, uscire dai confini dello stretto necessario per soddisfare piaceri stipati in frigoriferi, armadi, garage. Chi ha potere economico, compra. Chi ne ha meno, compra discount, di seconda mano, usato. La domanda richiama offerta produttiva; la produzione genera domanda (succedanea):
Il consumo ne è, quindi, la (in)diretta conseguenza. Una “conduzione a termine”, o un “logorio” brulicante di sostanze e materia, le cui scorie rimangono gettate nel mondo, e più o meno stipate qui o lì, a seconda dello spazio a disposizione. Il problema s’è fatto quantitativo: paradossalmente – e detto malamente – troppe persone “stanno bene”, e questo benessere ci ha portato al capitalismo e al consumismo, all’inquinamento e alle discariche, al cambiamento climatico dell’antropocene. Una linea retta, una freccia capitalista scagliata al centro dell’esistenza umana.
Ridiscutere l’idea di produzione e di consumo diventa essenziale se si vuole cambiare paradigma. Da un progresso lineare a uno circolare; da una crescita ascendente a una propagazione sferica, che non riguardi solo l’ambito tecnologico, ma che guardi alla società, al ben-essere del singolo in ogni sua parte, all’etica, alla natura simbiotica di umanità e Natura. Il ragionamento che ogni individuo dovrebbe intentare parte da ciò che consuma: “mi serve o non mi serve?”. Un vestito, la provenienza di un particolare cibo – la relativa stagionalità – come viene utilizzato un particolare device elettronico (la cura che se ne ha, come viene smaltito). L’Occidente può permettersi, dal proprio stato di benessere, il tempo per ripensare ai propri modi di consumo, per diminuirne l’impatto. Dal logorio al riutilizzo, a una nuova trasformazione d’uso della materia per piegare la linea retta in una ciclicità.
I rifiuti, in questo senso, possono diventare altro: un bene, una materia utile per altri contesti. Serve cambiare la visione collettiva sul mondo-oggetto, iniziando a profilare soluzioni, anziché problemi. E le soluzioni devono essere incanalate nella giusta misura, attraverso percorsi che permettano loro di essere utili e giuste, anziché profittevoli e massificate. Dal consumo alla produzione: non più nel qui-e-ora, bensì in un lungo periodo, in un “oltre” che comprenda in tono minore il bene per noi, nel presente, e anche il bene per coloro che vivranno nel futuro prossimo.
L’intergenerazionalità temporale è uno dei temi sui quali la nostra specie, “essere umana”, si sta interrogando per la propria sopravvivenza, a fronte di un clima in repentino cambiamento. Con i nostri atti di produzione e consumo siamo responsabili anche della vita di persone molto distanti da noi, nel tempo e nello spazio. Da privilegiati occidentali dobbiamo ritrovare l’essenza di ciò che serve, e saper riconoscere il superfluo di ciò che fa male, nel suo senso più profondo di distruzione e danneggiamento. Un nuovo paradigma economico ed esistenziale, per non ridursi, ritornando agli slogan del secolo scorso, al famigerato “produci, consuma, crepa” dei CCCP – Fedeli alla linea. Un presagio a cui nessuno vuole incorrere. Serve, quindi, trasformare: dalle parole, ai fatti; dal “crepare”, alla ripetizione sostenibile. Dal consumare la produzione, a produrre dal consumo.
di Damiano Martin